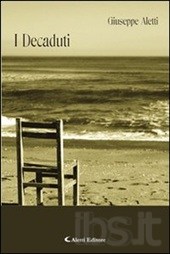 | Giuseppe Aletti – I DECADUTI – Ed. ALETTI 2011
Recensione di Carmen Lama
Forse sono state applicate delle ruote gigantesche a questo nostro mondo, a giudicare da come siamo trasportati, giorno e notte, a velocità impensabili fino a solo qualche decennio fa.
Forse le parole hanno smesso di funzionare come caratteristica peculiare e mezzo di comunicazione tra “umani” per assumere l’aspetto di stiletti, pronti all’uso, da scagliare indiscriminatamente contro chiunque pensi (ma si tratta di pensiero?) diversamente da noi.
Forse dalle troppe luci notturne e diurne si è generato il buio: è impossibile guardare “nel sole” ad occhio nudo senza provare immediatamente una sensazione di oscurità che si posa sulle nostre palpebre come un velo nero. Troppo abbagliati, storditi, da troppi luccicanti sfolgorii di (false) luci, siamo incapaci di distinguere le cose, le persone e ogni essere o oggetto della natura, allo stesso modo in cui siamo divenuti incapaci di soffermare il pensiero in modo critico su fatti ed eventi che ci riguardano, direttamente o indirettamente.
Il buio si estende dalla visione fisica a quella intellettiva.
Abbiamo di più, ma non sappiamo come utilizzare quel che abbiamo.
Forse, quelli che chiamavamo paesi e città, a misura d’uomo, sono diventati ingranaggi diabolici in cui l’andare è – deve essere – sincronizzato nei minimi dettagli, per non rischiare di uscirne stritolati.
E chissà se possano essere considerati paradigmatici di questo nostro convulso vivere di uomini (tecnologici) del secondo millennio i “fantastici” tapis roulants, su cui è sufficiente poggiare i piedi e non occorre altro! Ci muoviamo stando fermi. Dalle fiabe orientali abbiamo ripreso la fantasia del tappeto volante e l’abbiamo resa realtà. Ma con quale risultato?
Con il risultato di dover oggettivamente ammettere che forse il progresso evolutivo dell’uomo non può superare certi limiti. Il nostro divenire è immobile. E stando a una legge fisica, stare fermi mentre il mondo procede significa piuttosto regredire.
Forse questa prospettiva immaginata e qui delineata è una visione quasi apocalittica, eccessivamente negativa e perciò stesso frustrante.
Ma è dalla lettura delle poesie della prima silloge pubblicata da Giuseppe Aletti col titolo “I decaduti”, che sono stata inesorabilmente portata a queste riflessioni. E non intendo sminuire il punto di vista dell’autore e ritrattare quanto già scritto, sostenendo un’idea più ottimistica che avrebbe solo il compito di “un’illusione per farsi coraggio nella pena”, alla stregua di G. Ungaretti, nella sua poesia Pellegrinaggio.
Il poeta G. Aletti dà una precisa connotazione a questa sua raccolta poetica già a partire dal titolo, I decaduti, ed è al mondo dei poeti che riserva questo attributo. Con esso intende, credo, lasciar intuire più accezioni del termine, dal punto di vista concettuale. Provo ad indicarne alcune:
- I poeti al giorno d’oggi sono “decaduti” perché non sono minimamente presi in considerazione e la loro è “una voce che grida nel deserto”;
- sono decaduti perché in questo mondo frenetico non c’è posto per le anime “lente”, per le menti riflessive, per coloro che si ostinano non a cercare certezze, ma a cercare di carpire almeno un barlume di verità e di senso in questa nostra esistenza;
- sono decaduti perché la poesia è una scienza dell’anima e non serve che a se stessi, o meglio, serve solo a quei pochi, tra i “veri” poeti, che hanno l’umiltà di sentirsi sempre inadeguati e inappagati, rispetto alla complessità dell’universo di cui non rappresentano che un’infinitesima misura e parte e che, per questo, continuano in solitudine nella loro ricerca di senso che acquieti l’ansia dell’anima almeno temporaneamente;
- sono decaduti perché la loro poesia non produce e non consuma beni visibilmente materiali che rendano profitti;
- e ancora, e in definitiva, lo sono proprio perché, per tutte queste ragioni, altro non sono che degli “alieni”.
Ed ecco, allora, che la “vis po_etica” dell’autore insorge a difesa, non proprio (o non solo) dei poeti in quanto tali, bensì dell’essenza umana degli uomini di questo nostro tempo e di questo nostro spazio di vita. Il poeta sente e vede e dunque “sa” che essi stanno gradualmente abdicando alle proprie specificità e persino alle proprie peculiari esigenze di esseri umani, lasciandosi derubare del nucleo più prezioso dell’esistenza: l’anima, appunto.
Il suo, quindi, è un modo per far rallentare un po’ questo mondo in corsa, un modo per riappropriarsi della parola in funzione comunicativa, per tentare di riapprendere a vedere e a distinguere, in senso fisico e mentale, la realtà in cui siamo immersi; un modo per cercare di riappropriarsi di uno spazio umano individuale, che sganci ciascuno dall’ingranaggio mortale in cui funziona quasi come il chicco di grano nella macina del mulino, mentre una società che voglia dirsi veramente civile e umana ha bisogno di persone, vere, uniche, autentiche, e non di miscugli omogeneizzati.
Le poesie di G. Aletti hanno, dunque, sotto questo profilo, uno spessore culturale ed etico che si fa quasi dogma: “non si può e non si deve permettere a nessuno di agire come predatore delle nostre anime”, in qualunque forma si presenti (individui gruppi società mass-media internet o altre modalità tecnologiche, gruppi economici finanziari o altro ecc… ecc…); è urgente e necessario riappropriarsi del proprio sé.
Per il poeta, ciò è press’a poco il suo principale merito. Aletti lo indica chiaramente nella lirica “Poesia”: Malattia / che ignorata / urli / la tua presenza // Indelebile essenza / di attimi / orfani di tempo // Rivesti / sembianze / che eterne / giacciono // Sfinge di luce // Febbre.
Anche volendo, il poeta non può fare a meno di assecondare la malattia, la “febbre” poetica e di prestare ascolto all’urlo della poesia che si fa presente come indelebile essenza, (v. Yves Bonnefoy, La parola poetica) in attimi che sono al di là e oltre il tempo, che sono, anzi, l’assenza stessa di tempo. E, una volta esperito il proprio compito, la poesia acquista le sembianze del tempo eterno, e si fa luce, sfinge di luce, enigmaticità rischiarata.
Ma il poeta prefigura anche la propria morte, con rassegnata disperazione, quando nella lirica “La morte del poeta” medita che “Il sogno di verità / da comporre nella visione / si dilegua / nel dimesso mattino / di ore senza moto // Mi estinguo nella parola”. Se ne deduce un’intima sofferenza, una consapevolezza dell’estrema difficoltà del poeta a tracciare il proprio territorio esistenziale, benché, nel verso finale (“Mi estinguo nella parola”) non si pervenga alla vera morte del poeta, come potrebbe apparire dal senso strettamente etimologico e concettuale del verbo “mi estinguo”.
L’estinguersi “nella parola” indica piuttosto un immedesimarsi del poeta nelle parole che scrive, che quindi lasciano un’impronta nella coscienza di chi legge, facendo sì che il poeta viva attraverso le sue parole poetiche. Dunque, si tratta qui di una morte metaforica con cui si riscatta la vita del poeta, ed è una sorta di rivincita sul decadimento forzato a cui i poeti, insieme con gli altri esseri umani, sarebbero in qualche modo condannati o condizionati.
(Detto per inciso, è del grande Mario Luzi un pensiero simile, quando scrive, in Naturalezza del poeta, che il poeta “consegna i suoi scritti” alla vita ri-creativa che i lettori saranno in grado di conferir loro, poiché “la poesia continua a lavorare -oltre il poeta- a seconda del potenziale del linguaggio che in lei è racchiuso”).
Un’altra poesia molto significativa, in termini di riscatto del poeta, è “Fine”. Qui l’Aletti si abbandona ad una sorta di “pessimismo totale”, dove prevale l’annichilimento dell’esistenza del poeta, di cui non resterà nient’altro che “… immagini sbiadite / cancellate dal tempo,/ … un misterioso silenzio / orme sui cammini della civiltà”, come dire… “nulla”. Ma ecco, nel finale, il vero riscatto, la vera luce poetica, proprio là dove brillerà di più: “Saremo soli / dinanzi l’eterno”. Dunque l’esistenza del poeta continuerà oltre questo angusto e gretto tempo, oltre questo lacerante e vuoto spazio di vita, perché anche il misterioso silenzio del poeta è qualcosa di inaudito che potrebbe “atterrire l’universo”, come sosteneva Emily Dickinson.
C’è, si potrebbe dire, un’insistenza costante e perentoria, in molte delle poesie di questa silloge, sulla possibilità di capovolgere le situazioni negative in cui ci troviamo (perché “Rotaie / ci inoltrano / nel nostro destino”), per farle diventare positive.
Riporto, ad esemplificazione di questa mia affermazione, alcuni versi finali di qualche poesia: “Seduto, consapevole, / qui aspetto / la mia metamorfosi”, (in “Trasfugurazioni”);
oppure: “Aspetto / il mio passo / farsi strada”, (in “Evoluzione”);
o ancora, in un brevissimo flash poetico, dal titolo illuminante, Ostinazione: “Concepire / nel parto/ del quotidiano respiro”.
Questi tratti, forieri di speranza, imprimono a ogni quadro poetico una luce nuova: la luce della ragione che insistentemente aspira alla sua specifica funzione identitaria dell’essere umano e vuole farsi strada e vuole dichiarare il suo diritto di esistenza, trascinando nel suo vortice positivo il sentimento propriamente umano dell’essere per sé per poter meglio essere per gli altri.
E allora, in definitiva, secondo il mio modesto parere, le poesie di questa raccolta dovrebbero essere intese:
- in primo luogo, come una analisi obiettiva di una evidente situazione di disagio che accomuna poeti e non poeti, cioè una sorta di fotografia dell’esistente;
- in secondo luogo, come un tentativo di scuotere gli animi e di indirizzare i lettori verso una necessità di leggere la realtà con spirito critico, per tornare ad essere capaci di pensare in proprio;
- in terzo luogo, come dimostrazione che possiamo aprirci spiragli di futuro nuovo, senza lasciarci trasportare dagli eventi o irretire da usurai dell’anima, che ci danno solo false illusioni di dinamismo, mentre ci immobilizzano nel nostro procedere, senza farci avanzare di un passo nel progresso civile e morale, anzi facendoci arretrare.
In funzione di questa apertura verso una speranza di possibile cambiamento in positivo del nostro “vagare”, ritengo molto significativo il messaggio trasmesso dal poeta con queste sue liriche, poiché è un messaggio a forte valenza educativa. Dal punto di vista filosofico, direi che sono poesie classificabili nell’ambito di una certa “ontologia dell’esistenza umana”.
Si può apprezzare, infatti, uno sforzo intellettuale notevole, mirato principalmente a dimostrare in prima persona, con l’azione, che bisogna far sentire la propria voce, nonostante si abbia l’impressione di non essere ascoltati. Ma anche il modo peculiare di dire (poeticamente parlando) ha la sua importanza: si tratta di far sentire il proprio energico rifiuto di soccombere alle volontà negative del presente che dequalificano la persona umana e di opporvisi in ogni modo, mostrando con la propria “ostinazione” di voler essere protagonisti di un vero progresso civile, autenticamente umano.
Giuseppe Aletti ha, in effetti, un modo genuino di esprimere il suo pensiero in versi. Nell’Introduzione, fa esplicito riferimento all’uso di parole semplici e comuni che però, nella disposizione in versi, (nei versi particolari di queste poesie), assumono valenze diverse dall’ordinario sentire. Ed è vero, come ho potuto far notare in precedenza a mo’ di esempio, a proposito del verso “Mi estinguo nella parola”.
Colpisce, in particolare, la disposizione degli aggettivi che in molti versi precedono i sostantivi (alla maniera inglese) e che conferiscono maggior “volume” all’espressione poetica, poiché nella lettura obbligano a una presa “in carico” del termine-attributo qualificativo, in qualche modo anticipatorio del senso. Ma c’è di più.
L’intento dichiarato di Giuseppe Aletti era quello dell’utilizzo non casuale dello spazio grafico di ogni pagina che, a suo dire, avrebbe la struttura di quadro su cui le parole costituiscono i colori.
Ma sono quadri in cui le parole hanno un loro peso specifico, dove la prevalenza è dei colori scuri, dei toni un po’ cupi, mentre la figura che affiora dallo sfondo, che viene in superficie esaltata, soprattutto attraverso le aperture ripetute verso una luminosità futura dell’esistenza, è una positiva presa di distanza da tutto ciò che opprime le coscienze e, nello stesso tempo, l’attribuzione al poeta di un compito quanto mai utile, proprio nel momento in cui la sua presenza sembra essere stata definitivamente eclissata.
Lo stile dell’Aletti, in questa silloge, è dunque asciutto, denso, corposo.
Le parole, dure, compatte, pesanti come pietre, dovranno pur centrare il bersaglio!
E dopo, sarà possibile riprendere a camminare con le nostre gambe, senza tappeti volanti che, di per sé innocui, costituiscono un freno metaforico allo sviluppo individuale e sociale se utilizzati in sostituzione di più efficaci organi prettamente umani.
Maria Carmen Lama
Vai a vedere il Booktrailer
http://www.youtube.com/watch?v=hFilmSgHe9I
Diventa nostro amico su facebook
http://www.facebook.com/alettieditore
Seguici su twitter
http://www.twitter.com/alettieditore |

