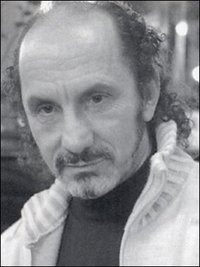 | «Aver avuto entrambi i genitori sordomuti, credo mi abbia insegnato da sempre che l’ascolto e l’osservazione sono importanti nella vita di tutti i giorni».
Vincitore del Premio Campiello con la splendida e intensa raccolta di racconti “Mandami a dire” (Bompiani, pp. 171, Euro 9,00), Pino Roveredo è uno di quegli scrittori la cui pagina trasuda una sincerità che si avverte a pelle, indipendentemente dall’avere letto un qualsiasi suo libro precedente a questo. Roveredo racconta la gente, il suo udito si è affinato avendo percorso, l’uomo Roveredo, strade difficili, fatte di continue discese in gole troppo buie perché da dentro fosse per un attimo possibile scorgere anche la risalita. Eppure, le lettere scritte per conto dei suoi compagni di prigionia, nel carcere dove Roveredo ha impegnato gioco forza parte di questo suo cammino, hanno forgiato l’anima dell’uomo e affilato la punta della penna con cui avrebbe scritto, negli anni a venire, racconti memorabili come quelli che compongono il libro “Capriole in Salita” (fresco di ristampa presso Bombiani, sempre) e raccontato storie dure e fortemente educative, di cui il romanzo “Ballando con Cecilia” rappresenta benissimo la summa. Collaboratore al “Piccolo” di Trieste, città dove vive, è nato e lavora, Pino Roveredo, classe 1954, si autodefinisce un “operatore della strada”. Ma per dirla con le parole che Claudio Magris ha usato in apertura al suo ultimo libro, “i personaggi di Roveredo vivono spesso ai margini della vita o dell’ombra; egli ne racconta con partecipe affetto e rispetto le violenze anche brutali e le umiliazioni subite, gli sbandamenti o le canagliate ma anche il generoso e spavaldo coraggio, le piroette e i capitomboli con cui essi cercano di sfuggire alla morsa della vita, i sogni ingenui ma potenti che li portano aldilà dei confini del reale”. Sembra il suo ritratto.
TI DEFINISCI UN OPERATORE DELLA STRADA. QUESTA DEFINIZIONE, CHE USI IN RELAZIONE ALLA SCRITTURA, COSA VUOLE SIGNIFICARE?
Significa incontrare la gente – e questo, chiaramente, avviene per la strada, frequentando luoghi. Trasferire le esperienze raccolte sulla pagina, traduce tutto questo in scrittura ed è possibile soltanto se si dispone di una capacità discreta nell’ascoltare le emozioni delle persone per trasmetterle poi a chi le legge così, senza troppe costruzioni, senza filosofeggiarci sopra in un secondo tempo. Le emozioni sono qualcosa di immediato e se non le si riporta con altrettanta immediatezza nella prosa, si rischierebbe la perdita di questo loro fondamentale valore. Aver avuto entrambi i genitori sordomuti, credo mi abbia insegnato da sempre che l’ascolto e l’osservazione sono importanti nella vita stessa di tutti i giorni, prima che altrove. E raccontare tutto questo mi è utile perché io mi trovo tuttora là, nelle storie che racconto, immerso in quelle derive.
PER “LÀ”, PINO, PARLIAMO DI CARCERE, PARLIAMO DI DIPENDENZA DALL’ALCOOL…
Parliamo di ricoveri psichiatrici, parliamo di gigantesche sconfitte e abissali delusioni che ho provato innanzitutto sulla mia pelle. Parliamo sicuramente di un mondo che vanta una credibilità nulla. Ti faccio un esempio molto banale, forse: visti i miei trascorsi, pochissimi avrebbero scommesso su di me, se non mia moglie – che ha scommesso su di me non solo come scrittore, ma come uomo, come persona. Per quanto riguarda chiunque altro, invece, esclusi i miei genitori perché nel frattempo mi sono venuti a mancare, nessun altro avrebbe creduto che io, Pino Roveredo, sarei riuscito a riemergere dai miei problemi facendo anche qualcosa di utile, in seguito.
È STATA QUESTA DISCESA E RISALITA NEL DOLORE A SPINGERTI VERSO LA SCRITTURA, O HAI SEMPRE NUTRITO IL SOGNO DI DIVENTARE UNO SCRITTORE?
Se mi chiedessero di scrivere del “Carnevale di Rio”, forse sarei in difficoltà. Io conosco il dolore, frequento il dolore e di dolore scrivo, tutto qui. Quando da bambino rientravo a casa dall’Istituto dove restavo chiuso durante il resto della settimana, facevo “lo scrivano” per gli inquilini del mio palazzo. Avevo sette, otto anni, non di più. Abitavo coi miei genitori e i miei fratelli in un rione molto povero, i tagli al gas o all’energia, piuttosto che un sequestro di mobili, erano all’ordine del giorno. Ricordo benissimo l’arrivo di questo camion enorme, che chiamavamo nel quartiere “il camion della morte”, perché sicuramente il suo passaggio significava la perdita dei beni per qualcuno di noi. Ecco allora che scrivevo lettere su lettere di supplica a questo o a quell’ente, per conto di quelle famiglie che temevano, a ragione, un imminente pignoramento, o peggio ancora la perdita totale di quei confort rappresentati dall’acqua corrente, dalla luce, dal riscaldamento. Cose normali per tantissima gente, ma autentiche ricchezze per coloro che avevano poco altro in una casa già modestissima di suo. È stato da allora che ho cominciato a scrivere, direi. Riscuotendo, per altro, un notevole successo. La scrittura infantile esercitava una certa pietà. E dato lo scopo…
UN SUCCESSO BISSATO ANCHE ANNI DOPO. SEI TORNATO A FARE “LO SCRIVANO” IN CARCERE, PER I TUOI COMPAGNI.
Per me la lettera è qualcosa di assolutamente vitale, di viscerale. Tuttora ricevo e spedisco a mia volta moltissima corrispondenza. Sono un uomo “di lettere” nel senso più vicino al termine stesso. E amo la lettera in senso classico. Ai detenuti, per esempio, continuo a scrivere solo ed esclusivamente a mano, sebbene potrei benissimo utilizzare il computer. Ma siccome so, essendoci stato anch’io, che in carcere nessuno può servirsi del computer per scrivere, e chiunque voglia comunicare i propri pensieri all’esterno deve farlo perciò con una penna e un foglio di carta, penso sia una forma di rispetto scambiare coi detenuti lettere scritte a mano. Si instaura perfino una sorta di galateo nel risultare reciprocamente comprensibili attraverso la cura della propria grafia. Quando dico che la scrittura mi ha salvato, non intendo abusare di un luogo comune, ma tento di riassumere con una singola frase la storia di una persona che si è trovata sola e che, come unico interlocutore per contrastare in qualche modo questa solitudine, ha avuto soltanto la scrittura. Nel mondo del disagio, sebbene nei romanzi se ne parli invece pochissimo, la scrittura e la lettura si frequentano molto. Chi non ha per forza di cose nulla da fare e vive costretto in una solitudine alienante, legge e scrive in una maniera che è davvero inimmaginabile dall’esterno.
E COME MAI ALLORA “DALL’ESTERNO” ARRIVA DI RADO UNA RISPOSTA A QUESTO STATO DELLE COSE? PERCHÉ LA NARRATIVA, UN PO’ DI MENO LA SAGGISTICA FORSE, SI OCCUPA COSÌ POCO DI SIMILI REALTÀ?
Perché non le frequenta. Oppure si pubblicano libri le cui pagine fanno del dolore l’attrazione principale con cui stupire il pubblico dei lettori. Il dolore è rispetto, è dignità, in primo luogo, e poi può benissimo evolversi in rinascita, rivalsa, felicità. Io, se potessi, concluderei ogni mio libro con la frase “E vissero tutti felici e contenti”. Sarebbe una grande vittoria poterlo fare. Detto questo, non riesco comunque a pensare dei finali particolarmente brillanti per i miei racconti, mi prenderei in giro da solo: conosco abbastanza bene la vita da sapere che si ha la fortuna di vivere un lieto fine assai raramente. Faccio una premessa in ritardo: io non scrivo per gli altri, scrivo per me. Il giorno che mi commissioneranno un romanzo e accetterò, sarà probabilmente il primo segnale decisivo per la mia fine, come scrittore.
NONOSTANTE LA VITTORIA AL CAMPIELLO? NON PENSI CHE UN RICONOSCIMENTO DI QUESTO TIPO SIGNIFICA CHE QUALCUNO, DALL’ESTERNO, LEGGE, DISCUTE E INFINE GIUDICA UN’OPERA IN FIN DEI CONTI PUBBLICA?
Sicuramente una vittoria di questo genere, che ha stupito tanti, me per primo, ha aperto varchi che prima non erano praticabili, in primis una maggior visibilità e diffusione dell’opera stessa. Che avviene però, e qui apro una mia piccola e privata polemica, attraverso canali sicuramente seri di studio e pratica della letteratura, talmente seri che finiscono col relegare certi autori in un ambito d’elite in cui fatico a riconoscermi. Ma questa, ripeto, è solo una mia impressione personale rispetto alla cosa. Mentre poco fa dicevo che è inutile giocare con troppa retorica quando si racconta la vita, che è meglio limitarsi a riportare le realtà che si raccontano senza filosofeggiarci sopra, cercavo la maniera più diretta per spiegare che confido e voglio possibilmente fare una narrativa vicina allo spirito dei lettori. Una voce amica, e semplice, e vera, come sono semplici e vere le storie della gente che io cerco da sempre di raccontare, in qualsiasi modo.
(Articolo di Gianluca Mercadante, pubblicato su Orizzonti n. 29 nella rubrica “Riproposti per voi”)
Continua a seguirci su facebook al seguente link:
www.facebook.com/rivistaorizzonti
|

